«Il governo tunisino è un insieme di fusibili, l’importante per il presidente è che nulla sia mai colpa sua». Con queste parole il saggista Hatem Nafti commenta il licenziamento del capo del governo Bouden da parte del presidente Saied. Un contributo per capire l’identità della Tunisia lo ha pubblicato la nuova rivista Comprendere quadrimestrale curato da Comin & Partners e coordinata dall’economista Giulio Sapelli. Il primo numero di Comprendere è dedicato all’Africa mediterannea. All’interno delle 120 pagine si susseguono le coordinate storiche e politiche del Marocco, dell’Algeria, della Libia e dell’Egitto. A tracciare quelle della Tunisia è stato Francesco Tamburini* professore dell’Università di Pisa. Lettera43 vi propone la sua analisi.

Tunisia, il falso mito della “diversità”
La Tunisia è sempre stata considerata “diversa”, una sorta di “eccezione” o “anomalia” in senso positivo rispetto al resto del mondo arabo, anche nei tempi più bui delle autocrazie di Bourguiba e Ben Ali, e soprattutto durante e dopo le rivolte del 2011. Le ragioni risiedevano nell’idea di Tunisianité immaginata e creata da Habib Bourguiba, il primo presidente della Tunisia indipendente. La pacifica decolonizzazione avvenuta nel marzo del 1956, la diplomazia di stampo occidentale, la centralità della borghesia nella società tunisina, la “laicità” e, infine, l’emancipazione delle donne con il Codice di Statuto Personale rendevano la Tunisia il Paese arabo più moderno nell’immaginario collettivo dei Paesi occidentali. Questa narrazione, estremamente apologetica e semplificata ha avuto effetti anche sulla storia più recente: gli eventi del 2010-2011 che avrebbero generato una vera democrazia in Nord Africa. La Tunisia, quindi, è stata considerata (acriticamente) come l’unica “storia di successo” del mondo arabo post-2011, per avere adottato una Costituzione nel 2014, definita la più democratica del mondo arabo secondo la rivista L’Histoire, aver tenuto molteplici elezioni, e, soprattutto, per l’elezione di quattro diversi Presidenti della Repubblica e otto primi ministri, confermando la possibilità di un cambiamento pacifico del potere in un Paese arabo. Nel 2014, The Economist nominò la Tunisia “Paese dell’anno”, l’anno seguente il Quartetto per il Dialogo Nazionale fu insignito del premio Nobel per la pace «per il decisivo contributo nella costruzione di una democrazia pluralista». Tutto ciò suggellò nella comunità internazionale l’idea di una Tunisia come la più democratica all’interno del mondo arabo. Tuttavia, la realtà era ed è molto diversa.
Il bourguibismo era stato nei fatti una “monarchia presidenziale”, dato che Bourguiba riteneva che il popolo tunisino non fosse sufficientemente maturo e razionale da poter partecipare democraticamente alla vita politica. Le elezioni erano giudicate come generatrici di «germi pericolosi alla salute della nazione», pertanto le occasioni in cui la volontà popolare potesse esprimersi liberamente erano sempre state ridotte al minimo. Nel marzo del 1975, Bourguiba fu eletto presidente a vita in virtù dei «servigi resi alla Nazione nella lotta contro il colonialismo e per avere fatto della Tunisia un Paese unito, indipendente e moderno». Anche l’economia era un problema: sovrappopolato, privo di risorse economiche e tecnici specializzati, ostacolato nei suoi rapporti internazionali da una politica estera a tratti confusionaria e indecisa se restare in campo occidentale oppure panarabo, l’ex protettorato francese sin dall’inizio non ebbe vita facile. La “tunisificazione” di molte professioni, così come la nazionalizzazione delle terre agricole nel 1964 portò alla lenta ma graduale emorragia delle comunità straniere, in primis quella italiana, rendendo ancora più asfittico il panorama economico.

Anche il successore di Bourguiba, Zine El-Abidine Ben Ali, subentrato al potere della Tunisia con il “colpo di stato medico” del novembre del 1987 che destituì un presidente malato e inabile al governo, godette dell’appoggio occidentale, sebbene non fosse mai riuscito a far intraprendere al Paese una vera svolta democratica. Arresti arbitrari, uso sistematico della tortura, controllo della libertà di espressione, inibizione di ogni forma di opposizione politica, sperequazione regionale – le zone interne e lontana dalle più ricche zone turistiche costiere – furono i fattori che portarono il regime di Ben Ali ad essere travolto dalle proteste del dicembre 2010 e la seguente rivoluzione del gelsomino. Ma i risultati di quella che fu anche denominata rivoluzione kar?ma, dignità, sono stati meno che modesti. Una vera transizione democratica non è mai avvenuta. A una democrazia elettorale, infatti, non è mai seguita una democrazia sostanziale, coerente con gli ideali del 2011 e le aspirazioni popolari. Dalla fuga di Ben Ali si sono succeduti ben 12 governi, che non hanno mai saputo distribuire giustizia sociale e dignità alla popolazione. Un sentimento di frustrazione crescente e di speranze tradite da parte di istituzioni che la gente comune ha sentito sempre più lontane. Molti diritti espressi nella Costituzione del 2014 – come il diritto al lavoro – non si concretizzarono mai e il clientelismo e la corruzione tornarono a insinuarsi in tutti i settori della vita pubblica. Alcuni sindacati di polizia divennero uno strumento di pressione politica, che giunsero a influenzare le decisioni dei tribunali contro gli abusi della polizia. Dal 2014, il parlamento, bloccato e diviso tra la corrente degli “islamisti” e laici, non è stato in grado di eleggere la Corte costituzionale, con grave nocumento per tutto il sistema politico, impedendo a nuove norme di penetrare l’ordine giuridico. A tutto ciò si aggiunge la disastrosa situazione economica accresciuta dalla pandemia del Covid 19. Oltre l’83 per cento dei giovani ha una istruzione superiore e non riesce a trovare un impiego, l’inflazione raggiunge il 6 per cento e i governi tunisini sono stati costretti a indebitarsi per fare fronte all’emergenza accumulando un debito pubblico superiore al 70 per cento – prima della rivoluzione era del 35. Si è accresciuto inoltre il già esistente divario tra le aree costiere e quelle interne. Tuttavia anche le regioni sulla costa, una volta più prospere grazie al turismo, iniziarono a ristagnare a causa della mancanza del turismo occidentale.

Il punto di svolta è avvenuto con l’elezione alla presidenza della repubblica di Kais Saïed nell’ottobre del 2019. Saïed, eletto come indipendente da una larga maggioranza e supportato da una ampia varietà partitica, ha presto rivelato la sua figura controversa nella scena politica tunisina. La sua agenda conservatrice e anti-sistema nascondeva in realtà un sostrato demagogico, a tratti paternalista, non solo quale strategia politica per imporsi nelle elezioni presidenziali, ma anche per progettare un edificio istituzionale che privilegiasse una figura ispirata al one man leading behind. Saïed ha cercato di costruire uno Stato basato su una politica indipendente dalla distinzione laico-religiosa pre-rivoluzionaria imposta da Bourguiba e Ben Ali, e soprattutto un regime ispirato a una narrazione anti-sistema. Infatti, egli ha apertamente accusato la precedente élite politica di aver volutamente disatteso gli obiettivi della rivoluzione, rendendoli fondamentalmente incompiuti. Con il decreto presidenziale n. 117 del 22 settembre 2021 Saïed ha obliterato senza ostacolo alcuno – né formale, né procedurale – la Costituzione del 2014, assumendo di fatto tutti i poteri e varando una nuova Costituzione nell’agosto del 2022 che sancisce la sua illiberal democracy. Saïed ricorda più il classico golpe africano stabilente un regime “riformatore” o “redentore”, che si autolegittima, cioè, per difendere la democrazia e la nazione dalla corruzione. Il paradosso risiede nel fatto che questo non sia avvenuto in un regime ibrido, sfocato e autoritario, ma in una giovanissima democrazia pluralista e altresì piena di speranze. Un solo uomo è stato in grado di smantellare un intero sistema politico e costituzionale senza alcun tipo di opposizione da parte delle istituzioni e alcuna forma di controllo sui poteri e i loro equilibri. L’“eccezione tunisina” si è rivelata, di nuovo, un mito, frutto della cultura occidentale.

*Francesco Tamburini insegna Storia e Istituzioni dei paesi afroasiatici presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa ed Equilibri geopolitici dell’Asia e dell’Africa nell’epoca post-coloniale. È ricercatore del settore scientifico disciplinare SPS-13 – Storia e Istituzioni dell’Africa. I suoi principali temi di ricerca sono il Maghreb, le istituzioni politiche e religiose del mondo arabo e il rapporto tra religione e politica. È in corso di stampa per i tipi della Pisa University Press: Storia, istituzioni, diritto potere nel “Grande Maghreb”.



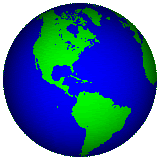



 IN SALVO SPELEOLOGA BLOCCATA NELLA GROTTA DEL FALCO, A SALERNO.
IN SALVO SPELEOLOGA BLOCCATA NELLA GROTTA DEL FALCO, A SALERNO. 43.03775, 47.45178).
43.03775, 47.45178).





