L’aspetto più tipico del Rossini Opera Festival appena concluso (era la 44esima edizione) è stato ancora una volta la sua internazionalità. Il Rof, per quanto numericamente piccolo, è un festival davvero planetario, di gran lunga il più “globale” che si organizzi in Italia. Uno spettatore su due viene dall’estero, non solo dai Paesi dell’Unione europea ma anche dagli Stati Uniti, dalla Thailandia, financo dalla Nuova Caledonia e dalla Costa d’Avorio, per non parlare della Corea del Sud, del Brasile, del Giappone. In tutto, le nazionalità presenti sono state 39; fra le più numerose quella russa, nonostante la guerra. In parallelo, resta molto elevata la copertura mediatica – altra caratteristica “storicizzata” del festival pesarese: accreditati 153 giornalisti provenienti da 23 Paesi, ormai nella maggior parte dei casi attivi in testate online più o meno autorevoli.
L’attenzione del pubblico si è un po’ inceppata
Nonostante il Rossini Opera Festival sia certamente internazionale, dal punto di vista dell’attenzione del pubblico appare però sostanzialmente fermo. Il numero di spettatori del 2023 è infatti quasi sovrapponibile a quello del 2022, l’anno della ripresa e della grande crescita dopo le due edizioni realizzate durante l’emergenza Covid. Nel 2022 gli spettatori erano stati 13.100, quest’anno sono stati poche centinaia di più, 13.576, peraltro “spalmati” in una quarantina di manifestazioni anche secondarie e decentrate nel territorio. La struttura portante della rassegna è però sempre la stessa da tempo: tre opere (con due nuove produzioni) più Il viaggio a Reims affidato ai giovani allievi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”, per un totale di 14 rappresentazioni, a cui si aggiungono sette o otto concerti vocali di alto livello. Sono queste manifestazioni che attirano il grosso del pubblico.

Un difficoltoso ritorno alla normalità post Covid
Solo cinque anni fa, nel 2018, il Rof aveva toccato il suo record di presenze, con 18.260 spettatori, ma già l’anno successivo si era registrato un calo di circa il 10 per cento (16.517). Quindi il crollo causato dalla pandemia, con numeri che ovviamente non fanno testo, ma danno l’idea dell’emergenza causata dalla crisi (meno di 6 mila spettatori nel 2020, 8.500 nel 2021). Due anni più tardi, il ritorno alla normalità appare molto meno semplice e meno scontato di quanto si potesse pensare. Il numero di 13.500 spettatori è tra i più bassi degli ultimi 15 anni e prima del 2022 e di quest’anno è stato toccato solo nel triennio 2009-2011, ma poi sempre anche abbondantemente superato.
Incassi scesi a 750 mila euro, la cifra più bassa dal 2007
A questa tendenza problematica, si aggiunge il dato relativo agli incassi, scesi a 750 mila euro dagli oltre 950 mila dello scorso anno. Si tratta della cifra più bassa dal 2007 (i dati si possono trovare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale del festival, fra bilanci e relazioni della Corte dei conti). Non è bastato il livello dei prezzi, quest’anno attestato a 200 euro per le prime e 180 euro per le repliche nei posti migliori, per garantire la tenuta: a quasi parità di pubblico pagante (nel 2022, anzi, un po’ meno numeroso), l’anno scorso l’incasso è stato superiore di 200 mila euro. Visitando poco prima del festival o durante il suo svolgimento il sito Vivaticket, gestore della vendita dei biglietti online, si poteva notare che la disponibilità di posti alla Vitrifrigo Arena – sede delle opere – era sempre ampia, talvolta assai ampia.

Quest’anno il festival non ha mai fatto registrare il tutto esaurito
La differenza negli incassi rispetto all’anno scorso, a parità di spettatori complessivi, si può quindi forse spiegare con il fatto che quest’anno il pubblico, in larga misura, ha scelto di assistere a manifestazioni con biglietti a prezzi assai più bassi di quelli degli spettacoli operistici. In pratica, nelle sue date principali, quest’anno il Rof non ha mai fatto registrare il tutto esaurito. E lo stesso destino è toccato ai concerti, compreso quello prestigioso di chiusura, con la Petite Messe Solennelle diretta da Michele Mariotti.
Grattacapi per il sovrintendente Palacio e il direttore artistico Flórez
Non mancano dunque i motivi di preoccupazione per il sovrintendente Ernesto Palacio e il direttore artistico Juan Diego Flórez, entrambi cantanti rossiniani di vaglia (il primo ritirato da tempo, il secondo ancora in piena attività). I conti sono in ordine (il bilancio 2022 ha chiuso con un utile di oltre 300 mila euro, che torna buono con i chiari di luna degli incassi 2023), ma per recuperare i 5 mila appassionati che non sembrano più disposti a farsi attrarre dalla sirene rossiniane del festival pesarese, e magari per provare ad aumentarli e superare quota 20 mila, ci vorrebbe un cambio di passo che per il momento Palacio (che è stato un paio di anni fa confermato fino al 2026, avendo iniziato il suo mandato nel 2017) non sembra in grado di garantire.
Regia, scelte improntate a una prudenza eccessiva
Il fatto è che il Rof deve trovare una nuova dimensione dopo il quarantennio glorioso che lo ha posto in prima fila nella Rossini Renaissance, grazie alla sinergia vincente fra gli studi musicologici della Fondazione Rossini e una formidabile spinta propulsiva per quanto riguarda gli spettacoli, attuata del creatore del festival, Gianfranco Mariotti, oggi 93enne, che ha passato la mano proprio a Palacio. Quest’estate, con Eduardo e Cristina, è stato completato il periplo di tutte le 39 opere del Pesarese. Ciò è avvenuto peraltro in un’edizione infarcita di sofisticate rarità, tutta improntata al genere serio, che comprendeva anche Aureliano in Palmira e Adelaide di Borgogna. Forse è semplicistico ritenere che una simile offerta non abbia attirato il pubblico più di tanto, ma certo fino a oggi la gestione Palacio (sempre al netto dei due anni pandemici) da un lato non è mai sembrata in grado di trovare l’equilibrio migliore fra generi e valori drammatici, e dall’altro è sembrata fin troppo conservativa per quanto riguarda le scelte nella realizzazione degli spettacoli. Non tanto sul piano vocale (qui si ascoltano spesso, se non sempre, i migliori specialisti rossiniani), quanto per le regie, con proposte fra il conservativo e l’innovativo che appaiono il più delle volte improntate a una prudenza lontana dalla forza innovativa del festival nei suoi anni più fulgidi.

E il 2024 è l’anno di Pesaro capitale italiana della cultura…
Sintomatico, da questo punto di vista, il programma dell’anno prossimo, irrobustito perché il 2024 è l’anno di Pesaro capitale italiana della cultura, evento che dovrebbe garantire una maggiore attenzione da parte di un pubblico più generalista. Le nuove produzioni resteranno due: Bianca e Falliero ed Ermione. Si tratta di opere fondamentali del serio-tragico rossiniano, assenti entrambe al festival da quasi 20 anni. Lo sforzo produttivo (al netto delle voci: e sarà questione cruciale) si coglie anche nelle scelte per i direttori, bacchette di prestigio e valore come quelle di Roberto Abbado e Michele Mariotti. Per la regia, si passerà dal “rassicurante” francese Jean-Louis Grinda (che quest’estate era di scena nel vicino Sferisterio di Macerata) al tedesco Johannes Erath, che si è messo in luce con spettacoli di forte impatto a Graz e a Francoforte. Evidente la politica dei contrappesi, che si rispecchia anche nella parte dedicata al genere comico, fra l’arcinoto Barbiere di Siviglia (con la ripresa di una regia pesarese del 2018 di Pier Luigi Pizzi) e il minore (molto minore) Equivoco stravagante che per non essere fra i capolavori gode al Rof di una singolare fortuna e torna in scena in media ogni cinque anni.
La routine non si addice a Rossini: qualcuno ha dimenticato la lezione?
Non adeguata, si può dirlo fin d’ora, la celebrazione del quarantennale della prima assoluta del Viaggio a Reims, avvenuta nel 1984, con Claudio Abbado sul podio e Luca Ronconi a firmare la regia. Quello era stato uno spettacolo formidabile da tutti i punti di vista, l’evento unico e straordinario capace di lanciare nel mondo l’appena nato Rossini Opera Festival. Quarant’anni dopo, nessuna nuova produzione di quest’opera geniale, ma una prudenziale esecuzione in forma di concerto affidata a Diego Matheuz. La routine non si addice a Rossini: la lezione di 45 anni di Rof è questa, ma a quanto pare chi lo guida oggi ha idee diverse.



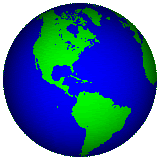

 (@dariosci1)
(@dariosci1)  Charles-Louis de Montesquieu
Charles-Louis de Montesquieu Anna Magnani e Pier Paolo Pasolini ballano il twist. Venezia 1962
Anna Magnani e Pier Paolo Pasolini ballano il twist. Venezia 1962 Evaristo Fusar
Evaristo Fusar 




 ).
).




















