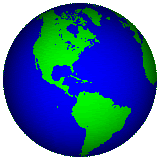Archivio
- Agosto 2025 (10)
- Luglio 2025 (41)
- Giugno 2025 (24)
- Maggio 2025 (9)
- Aprile 2025 (80)
- Agosto 2024 (1)
- Dicembre 2023 (73)
- Novembre 2023 (1333)
- Ottobre 2023 (1631)
- Settembre 2023 (1468)
- Agosto 2023 (1417)
- Luglio 2023 (1389)
- Giugno 2023 (441)
- Maggio 2020 (30)
- Marzo 2020 (65)
- Gennaio 2018 (10)
Il mio viaggio in treno verso Malpensa con i lanzichenecchi: il racconto della settimana
La vigilia di Natale sono entrato nella libreria del mio quartiere per cercare una guida di Tangeri da regalare ad Ofelia per un viaggio in Marocco che avevamo in programma e che in realtà non abbiamo mai fatto. Mi ero lasciato conquistare dall’idea di rifugiarmi qualche giorno tra la casbah e la Medina marocchina suggestionato dalla letteratura che in quel periodo mi era capitata tra le mani. Ero rimasto stregato dalle suggestioni che quella città internazionale che profumava di kif e marijuana, di spie, di bar tenuti da espatriati molto simili all’Humphrey Bogart di Casablanca mi regalava. Mi vedevo già con il mio completo di lino beige coloniale e il mio panama Montecristo da 2K avvinghiato al mio triplo gin tonic, come Ian Fleming mentre scriveva il suo ennesimo James Bond, seduto ai tavolini dell’Hotel Minzah. «Quest’anno, non si va a Cap Ferrat», sentenziò una volta la scrittrice americana Gertrude Stein fissando negli occhi il giovane e biondo Paul Bowles, «si va a Tangeri!». Anche se poi in realtà con Ofelia siamo andati due volte a Cap Ferrat e nessuna a Tangeri. D’altronde né io né lei abbiamo mai conosciuto Gertrude Stein. Tuttavia quel pomeriggio della vigilia di Natale, girovagando per gli scaffali della libreria del mio quartiere, rimasi rapito dalla copertina di un’altro libro: la monumentale biografia, scritta da Blake Bailey, di Philip Roth, sopra la quale troneggiava una fantastica foto in bianco e nero dello scrittore americano, adagiato mollemente, in una posa pensosa davanti ad una finestra. Così lo presi in mano, iniziai a sfogliarlo, a soppesarlo e a prendere confidenza con quella carta ruvida e profumatissima di oltre mille pagine. L’equivalente cartaceo di un maglione di cachemire. «Fanculo a Tangeri», mi dissi, e senza pensarci troppo lo tirai su. Anche se di Philip Roth non avevo mai letto niente in vita mia. Tre giorni più tardi ero già alla Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele a comperare Lamento di Portnoy e Pastorale americana, due tra i più acclamati capolavori di Roth, con l’aggiunta di un libro di racconti di Woody Allen, solo perché avevo letto da qualche parte che i due si erano sempre detestati e l’idea di metterli insieme nella stessa busta e portarli a casa, così per fare a entrambi un dispetto, mi divertiva parecchio.
Raramente si è folgorati dai libri, specialmente per noialtri che con i libri ci lavoriamo, ma mi ricordo che Portnoy riuscì nell’impresa di mandarmi letteralmente fuori di testa come ai tempi accadde con Il giovane Holden, Arancia Meccanica, Bastogne o American Psycho. Il romanzo è un lungo monologo di Alexander Portnoy, l’ebreo americano protagonista del titolo, rivolto al suo psicoanalista. Un po’ come Woody Allen, (sempre lui), in Annie Hall tracciava, durante il racconto della sua storia con Annie, un perfetto percorso psicologico, così Roth faceva con Portnoy, riportando per filo e per segno il suo torrenziale vaniloquio. La cosa mi fece immedesimare a tal punto che mentre il tipo parlava delle peggiori nefandezze, del tormentato rapporto con la madre e di tutte le sue nevrosi ebraico-newyorkesi, vedevo dall’altra parte ad ascoltarlo la faccia del mio psycho (90 euro a seduta). Natalia Ginzburg in una sua recensione su La Stampa del 22 marzo 1970 scrisse: «L’analista non ha voce, e non ha consistenza né dimensione. Potrebbe tacere sempre – come tace – ed essere però una presenza. Potrebbe avere una sua oscura e misteriosa realtà. Non ne ha nessuna. È una sedia vuota. Certo l’autore non aveva in testa, per questo analista, nessun volto umano. Se avesse un volto, lo sentiremmo respirare nell’ombra. Invece no. In quel vuoto, si avverte invece l’autore con una sua volontà cartacea, la volontà di metter là un analista perché la confessione di Portnoy sembri più vera». Io pensavo esattamente il contrario.
Quel pomeriggio di luglio cambiai lo sguardo su mio padre che, per la prima volta, vidi davanti a me per quello che era: non più un supereroe ma un semplice essere umano di 84 anni. Fino a allora mi aveva generato, criticato, distrutto. Quel giorno usciti dallo studio del mio psicologo decisi che non glielo avrei mai più permesso
La prima volta che entrai nello studio del mio strizza lui riceveva ancora al piano terra di un caseggiato in una piccola via dietro Porta Venezia. Doveva essere il 2008, credo. Mia zia era morta da un paio d’anni, mio padre viveva all’estero ormai da un’eternità, con Allegra andava sempre più di merda e la mansarda dove abitavo in via Tiepolo “puzzava stabilmente di marijuana e freebase”. Ricordo che come prima cosa mi diede una matita in mano e mi fece fare un cerchio su un foglio con un piccolo puntino al centro, chiedendomi di inserire all’interno della circonferenza le persone che più erano importanti per me. Io diligentemente presi la matita e, senza pensarci troppo, prima inserii i nomi di tutti i miei amici e poi, sparsi qui e là, dentro e fuori dal cerchio, quelli di qualche ragazza. Ricordo che rimase sbalordito quando si rese conto che nell’elenco non era stato messo nessuno dei miei famigliari. In definitiva, consigliato da DFA, avevo deciso di rivolgermi a lui non tanto per analizzare la mia disastrosa condizione esistenziale ma per un motivo più pratico: da circa un paio di settimane ero vittima di violenti e continui attacchi di panico e mi arresi rapidamente al fatto che per risolvere la questione avevo bisogno di aiuto. Sorprendentemente l’apporto dello strizza fu quasi miracoloso e in breve tempo gli attacchi di panico così come erano arrivati se ne andarono. Se mi guardo indietro considero il 2008 per una serie di motivi una sorta di spartiacque, come fosse l’inizio della mia svolta personale che probabilmente senza il mio strizza non sarebbe mai avvenuta.
Arrivavo da anni di devastazione rigorosa e sistematica, fisica e mentale. Orari folli, alimentazione sballata, inconcludenza totale. E così, durante quell’anno terribile, ci furono l’inevitabile programma di disintossicazione, le infinite seconde possibilità, le continue ricadute, le scivolate nell’abisso dell’orrore, il panico e, infine, l’esplosione. Dopo un anno di sedute però sentivo di stare un po’ meglio e probabilmente fu per questo che risalii immediatamente la china. Se dovessi segnare due punti cardinali del periodo della terapia sicuramente sceglierei come primo la risoluzione del problema degli attacchi di panico e, immediatamente dopo, l’incontro che avvenne un pomeriggio di luglio del 2009, nel quale mio padre spiegò la finanza degli Anni 80 al mio psicologo. Papà si trovava casualmente in città non ricordo bene per quale motivo e sorprendentemente accettò di presentarsi all’appuntamento con me e il mio strizza. «Se è importante per te vengo volentieri», mi rispose al telefono un paio di giorni prima e nonostante il caldo soffocante si presentò davanti allo studio nella piccola via dietro Porta Venezia, vestito di tutto punto, con tanto di completo estivo blu di Brooks Brothers e cravatta a pois di Marinella, e oltretutto in perfetto orario. Per tutta la sua vita mio padre aveva quasi sempre lavorato in apnea, senza mai venire in superficie. In tutta la sua carriera non ha mai rilasciato un’intervista completa, di peso. Non una parola ai giornalisti sui suoi affari, sulle sue passioni, sui suoi programmi. Non fosse stato per le inchieste collegate alla Montedison e a Raul Gardini, il suo nome sarebbe rimasto nell’ombra. Un po’ finanziere e un po’ brasseur d’affaires, molto bocconiano e di buona famiglia, raccontò tutta la sua vita al mio strizza quel pomeriggio di luglio del 2009 partendo dal giorno in cui finiti gli studi in via Sarfatti decise di mettersi a vendere film. «Non avrei mai pensato di mettermi a lavorare con la finanza», disse a un certo punto. Parlò poco di noi, ma si soffermò parecchio sul giorno in cui fu costretto a chiudere il suo ufficio, l’attico giungla pieno zeppo di ficus Benjamin, 650 metri quadrati affacciati su Piazza San Babila, e di opere che aveva collezionato negli anni e che andarono all’asta. «Le valutarono 4 miliardi e mezzo. La passione di una vita», disse, «quasi tutta messa insieme nella seconda metà degli Anni 80». Non una parola sulle case intestate a mio fratello che costrinse con l’inganno a farsi cedere per poi vendere. Non un accenno al fondo fiduciario lasciato a me da mia madre che gestì con la complicità delle banche e che svuotò completamente. La sua difesa, agguerrita e convinta, si basò completamente sulla tesi che «per fare affari bisognava stare a certe regole e giocare in serie A non era come partecipare a un pranzo di gala». Per quanto la seduta non toccò mai per tutto il tempo l’argomento del rapporto tra padre e figlio risultò per me sorprendentemente risolutiva, perché quel pomeriggio di luglio cambiai lo sguardo su mio padre che, per la prima volta, vidi davanti a me per quello che era: non più un supereroe ma un semplice essere umano di 84 anni. Fino ad allora mio padre mi aveva generato, criticato, distrutto. Quel giorno usciti dallo studio del mio psicologo decisi che non glielo avrei mai più permesso.

Non tornai nello studio del mio psicologo, che nel frattempo si era trasferito nella più centrale via del Torchio, per circa nove anni. Fino al giugno del 2018. Ricordo che in quel periodo stavano girando un documentario su di noi e sulla nostra idea di radio itinerante. La troupe ci aveva seguito fino all’Isola d’Elba dove avevamo progettato una serie di trasmissioni in barca a vela. I pirati, ci chiamavano. Eravamo deejay ma anche giornalisti d’assalto, io avevo 38 anni e Alb 35 e in cuor nostro, finalmente, credevamo di avercela fatta davvero. Per me era come vivere una seconda giovinezza e la naturale evoluzione di quando a 24 anni divenni famoso come “il vocalist dell’anno”, cosa che comportò articoli sui giornali, interviste in programmi televisivi in seconda serata e la trasformazione del mio personaggio, fatto tutto di apparenze, punk e ribellione, in una storia sexy da raccontare agli amici o a qualche cena con i propri familiari. Nel 2004 tornato da un’estate trascorsa a Tenerife al Royal Country Club per un breve periodo mi fidanzai con quattro ragazze contemporaneamente e tutte le porte in città mi si spalancavano davanti. Con Allegra ci mettemmo praticamente insieme durante quella vacanza alle Canarie e una volta tornati in città diventammo la coppia più chiacchierata del momento. Tipo Pete Doherty & Kate Moss. Ma con più droga. C’erano sempre altre ragazze e soprattutto altri ragazzi. Allegra diceva che la sua attrazione per “i cattivi soggetti” era come una droga e che la mia “imprendibilità” la eccitava. Poi le luci della ribalta si spensero e seguirono due aborti, un overdose e gli attacchi di panico di cui sopra. Poi passarono gli anni, arrivò Ofelia e grazie a lei mi gettai a capofitto nella nuova vita che mi veniva offerta. Ripartii da zero e mi illusi che in quella estate del 2018, all’Isola d’Elba, le luci della ribalta che volevo assolutamente riottenere si fossero riaccese per sempre. Evidentemente mi sbagliavo, ancora una volta. Ero diventato una persona molto diversa da quella che ero stata in precedenza. Consapevole, matura, affidabile. Avevo lavorato sodo per ottenere quel poco che avevo e non avevo nessuna intenzione di rinunciarci. In realtà anche quella volta ero semplicemente perso nei sogni su me stesso e nonostante tutto la realtà mi era sfuggita di mano.

Fortunatamente c’era Ofelia e c’era il lavoro al bar a tenermi ancorato a terra. Ma non bastavano. La mia vita attuale nonostante tutto mi opprimeva. Fu per questo che decisi di tornare dal mio strizza, o forse anche solo per dimostrargli quanta strada avevo fatto nei nove anni in cui non ci eravamo visti. Dopo un paio di sedute partii per la Grecia e passai le vacanze bevendo bloody mary nella super-villa da 10 mila euro al mese che la famiglia di Ofelia aveva affittato a Sèrifos. Leggevo romanzi di autori americani o giapponesi, continuamente, per tutto il giorno steso al sole ed ero “totalmente fuori di testa” & “troppo concentrato su me stesso”. Perciò poteva essere semicomprensibile che Ofelia mi lasciasse e che dopo avermi definito uno «stronzo egoista» filasse via sulla Porsche presa a nolo da sua sorella Cleopatra. E invece no. Paradossalmente quella fu l’estate in cui ci ritrovammo e ci legammo l’uno all’altra ancora di più. «Dio è greco!», urlavo in mezzo alla strada a pochi metri dalla spiaggia che avevamo sotto casa e il giorno in cui finirono le vacanze ricordo che piansi come un bambino. Non volevo più tornare indietro. Fosse stato per noi saremmo rimasti lì in eterno, in quel non-luogo sospeso dalla realtà. Durante l’inverno invece ce ne tornammo a New York. Perché era lì che dovevo stare per capire come evolvermi ancora e perché era lì l’epicentro musicale e culturale della wave che volevo seguire. Affittammo un appartamento sulla Quinta, tra il Flatiron e Union Square, e il giorno di Natale, quando andammo da Whole Foods a fare colazione con addosso i nostri maglioni in shetland e i nostri parka pesanti, ricordo che eravamo così felici che ci sembrava di stare nel posto più bello del mondo.

Penso a tutto questo mentre in treno scorro le foto sull’iPhone e rivedo parte dei momenti che vi ho raccontato, uno dopo l’altro, con lo slow-motion, mentre sto per partire per le vacanze. Nella testa le immagini si mischiano a un sacco di altri pensieri che vanno dal romanzo che mi sono messo in testa di scrivere al podcast letterario che ho intenzione di produrre l’anno prossimo, agli articoli che devo consegnare ai giornali entro fine mese, alla casa per settembre da prendere in affitto a Camogli. Trovo incredibile che al giorno d’oggi non ci sia una fottuta prima classe sul treno da Milano Centrale a Malpensa e si debba essere costretti a viaggiare in compagnia di un gruppo di Lanzichenecchi con in testa cappellini da baseball con visiere a tesa larga e musica assordante sparata nelle orecchie. Io nonostante il caldo indosso un vestito di lino tutto stazzonato e una camicia leggera e Ofelia, di fronte a me, un vestito a fiori di Lisa Corti, dal sapore vagamente indiano. Quando c’è classe regaz, che ve lo dico a fare. Meno male che ho la mia cartella di cuoio marrone dalla quale non mi separo mai, nemmeno sotto la doccia, dove custodisco gelosamente la mia mazzetta di giornali che comprende il New York Times, anche se non parlo una parola d’inglese, Le Monde, anche se non so il francese, e una mezza dozzina di quotidiani italiani che non nomino perché, a parte ovviamente quelli per cui lavoro, fanno così decisamente cacare che li compro tanto per darmi un tono ma non li apro nemmeno. A parte le pagine della Cultura, ovvio, che poi sono quelle sulle quali scrivo io. Cerco di estraniarmi, tengo tra le mani un’edizione francese di un libro dello scrittore inglese Julian Barnes e sono indeciso se scrivere la fine di questo racconto con la mia stilografica sul mio taccuino Moleskine oppure andare a masturbarmi in bagno, guardando un video porno sull’iPad per poi pulirmi con il fazzoletto che appositamente porto sempre con me nel taschino della giacca. Mentre il treno si ferma a Saronno (non pensavo che un treno diretto a Malpensa potesse passare addirittura per Saronno), mi guardo intorno e non capisco dove vada tutta questa gente, quando intorno a noi il cambiamento climatico sta uccidendo il mondo sempre più velocemente facendo bruciare la Grecia e la Sicilia e devastando Milano con uragani notturni di grandissimo spessore. Ma fatto sta che il treno arriva al Terminal 1 e sono costretto a scendere guardandomi intorno e sorprendendomi del fatto che nessuno di quei giovani in bermuda e sneaker ultracolorate non solo non si sia avvicinato a me per chiedere un autografo o, che so, una foto, ma oltretutto nessuno mai mi abbia rivolto la parola e addirittura fatto un cenno di saluto (Ero forse diventato nuovamente irrilevante?). In fondo per loro non esisto, sono solamente un uomo di mezza età, con la giacca e i pantaloni lunghi, che legge giornali in inglese e libri in francese e che, a un certo punto del viaggio, si è dovuto calare una pastiglia di viagra anche per farsi una sega. Vabbè, sicuramente Portnoy avrebbe apprezzato, il resto è noia avrebbe detto qualcuno, perché in fondo a me di questi quattro ragazzini non me ne frega veramente un cazzo.