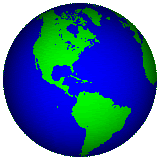Archivio
- Luglio 2025 (31)
- Giugno 2025 (24)
- Maggio 2025 (9)
- Aprile 2025 (80)
- Agosto 2024 (1)
- Dicembre 2023 (73)
- Novembre 2023 (1333)
- Ottobre 2023 (1631)
- Settembre 2023 (1468)
- Agosto 2023 (1417)
- Luglio 2023 (1389)
- Giugno 2023 (441)
- Maggio 2020 (30)
- Marzo 2020 (65)
- Gennaio 2018 (10)
Niger, i rischi per il Sahel e le mire della Russia
A una settimana dal golpe che il 27 luglio ha rovesciato il presidente Mohamed Bazoum, e mentre è in corso l’evacuazione da parte di Francia e Italia dei propri connazionali, il 2 agosto il Niger ha riaperto i confini terrestri e aerei con cinque Paesi limitrofi – Algeria, Burkina Faso, Libia, Mali e Ciad. Tra cinque giorni scadrà l‘ultimatum per ripristinare l’ordine costituzionale richiesto dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) che non ha escluso l’uso della forza in caso la scadenza non venisse rispettata. Giovedì una delegazione dell’Ecowas, guidata dall’ex presidente nigeriano Abdulsalami Abubakar, si recherà domani a Niamey per un tentativo di mediazione. Intanto a livello internazionale crescono le pressioni sui golpisti: l’Ue, la Francia e la Germania hanno sospeso i loro aiuti al Paese, economicamente dipendente da alleati stranieri.

Flussi migratori e lotta al terrorismo: perché il Sahel è un’area strategica
Dopo la deposizione di Bazoum, democraticamente eletto nel 2021, ha preso il potere il generale Abdourahamane Tchiani, capo della guardia presidenziale che proprio Bazoum stava cercando di smantellare. Da giorni si svolgono nel Paese manifestazioni di sostegno a Tchiani, con tanto di bandiere russe e slogan a sostegno di Mosca. La situazione è grave, soprattutto per le potenze europee che contavano sul Niger per stabilizzare il Sahel, regione subsahariana fondamentale per il controllo dei flussi migratori e per il contrasto al terrorismo. E dove si trovano ampi giacimenti minerari. Per dare un’idea il Niger, uno dei Paesi più poveri al mondo con un Pil pro-capite che nel 2020 non arrivava a 600 dollari, fornisce circa il 7 per cento delle riserve mondiali di uranio.

La mire della Russia che attraverso la Wagner si è sostituita alle forze armate occidentali
Negli ultimi tre anni nel Sahel si sono verificati tre colpi di Stato – due in Mali e uno in Burkina Faso – che si sono conclusi con l’espulsione delle forze armate occidentali, impegnate nell’area in operazioni di addestramento alle forze locali e di supporto nel contrasto ai gruppi jihadisti. Al loro posto è subentrata la Russia attraverso il gruppo Wagner. Un copione che potrebbe ripetersi anche in Niger, Paese dilaniato dai colpi di Stato sin dall’anno della sua indipendenza dalla Francia nel 1960 e dove il penultimo golpe risale al 31 marzo 2021, due giorni prima del giuramento di Bazoum. Non a caso, in un audio la cui autenticità però non è stata verificata, il fondatore della Wagner Yevgeny Prigozhin ha dato il suo «pieno sostegno» alla «sollevazione anti-colonialista» nel Paese. Anche se né agli Usa né all’Ue risulta che ci sia stata una regia russa dietro al colpo di Stato. Anzi, Mosca ha rivolto un appello per i negoziati, perché, si legge in una nota, «la minaccia dell’uso della forza contro il Niger non contribuirà alla risoluzione del conflitto». «Riteniamo estremamente importante non consentire un ulteriore degrado della situazione nel Paese. Chiediamo di garantire un dialogo nazionale per ripristinare la pace civile, la legge e l’ordine», ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Vero è che nella fascia subsahariana la presenza della Wagner è radicata. I mercenari alimentano la visione di Mosca come alleato fedele dell’Africa anche in nome della sua “storica” opposizione al colonialismo, che risale ai tempi dell’Unione Sovietica. L’Urss si era infatti garantita un’ampia sfera di influenza nel Continente, dalla Libia al Mali, sostenendo i processi di decolonizzazione. Da lì Mosca e la Wagner sono ripartite, in parte riscrivendo la storia, in parte sfruttando vecchi legami stretti soprattutto tra i militari, molti dei quali addestrati in Urss. Wagner offre anche servizi di sicurezza ai leader africani, addestramento e sostegno alle truppe. In cambio impone la Russia come fornitore di armi, mezzi ed equipaggiamenti per gli eserciti locali. Secondo l’Ispi, nel 2022 la Russia avrebbe fornito il 40 per cento delle commesse militari in Africa, là dove Stati Uniti, Cina e Francia rappresentavano rispettivamente il 16, il 9,8 e il 7,6 per cento del totale. Oppure pretende per la Federazione i diritti esclusivi per lo sfruttamento delle risorse, come nel caso del Sudan dove la Russia dal 2014 – anno d’inizio della guerra nel Donbass – ha messo le mani sull’oro del Darfur. Un interesse, quello di Mosca, che alimenta problematiche preesistenti, in una spirale di instabilità che danneggia soprattutto la popolazione locale, stretta nella morsa della povertà e della violenza, spesso costretta all’emigrazione.

Come il Sahel è diventata la nuova provincia dello Stato islamico
La sequela di colpi di Stato nel Sahel e l’instabilità politica dell’area sono causate da una cronica crisi democratica. Non va dimenticato poi che anche il Senegal, un altro Stato considerato fondamentale per la stabilizzazione dell’area e che fino a poco tempo fa era citato come esempio virtuoso, è attraversato da forti tensioni. Le istituzioni vacillano per la corruzione diffusa, ma anche per la crisi economica cui si è aggiunta la carenza di grano e mais. Non è un caso che il colpo di Stato in Niger si sia consumato negli stessi giorni in cui Putin teneva a San Pietroburgo il summit con i capi di Stato africani promettendo di fornire al Continente tonnellate di grano. Il presidente russo sa bene, infatti, che può sfruttare la leva delle forniture alimentari per soffiare sull’instabilità del Sahel, aumentando i prezzi dei beni alimentari o provocando delle carestie che andrebbero ad accrescere i flussi migratori e, quindi, la pressione sugli Stati nordafricani ed europei. C’è poi la questione sicurezza. La regione è una prateria sia per i trafficanti di esseri umani sia per i gruppi jihadisti che le missioni occidentali e le forze armate locali non hanno saputo arginare. Nel 2022 il Sahel è stato proclamato «provincia dello Stato islamico in Africa». Nello stesso anno sempre Daesh ha condotto metà dei suoi attacchi nel continente africano, considerato ormai la nuova frontiera del jihadismo globale. Nell’ultimo anno le violenze dei gruppi fondamentalisti hanno raggiunto un nuovo record, con un incremento del 22 per cento rispetto all’anno precedente, mentre il numero delle vittime è salito del 48 per cento secondo il think tank Africa Center che ricorda come il 40 per cento delle attività dei miliziani si svolgano nel Sahel. Nell’ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere (RSF) l’area è definita una «no-news zone», una zona priva di copertura informativa.

La presa di Mosca sull’Africa potrebbe indebolirsi
Il summit di San Pietroburgo ha fornito due indicazioni. Molti Stati che si servono della Wagner erano preoccupati dalle possibili ricadute del tentato colpo di Stato di Prigozhin. La presenza di quest’ultimo al summit dovrebbe averli tranquillizzati. Ma il fatto che solamente 17 leader africani, contro i 43 dell’edizione del 2019, abbiano preso parte all’incontro potrebbe essere un segnale di indebolimento della Russia in Africa. Del resto, se la maggioranza degli Stati africani alle Nazioni Unite si è astenuta dalle votazioni sull’Ucraina, di fatto aiutando la Russia, solamente due Stati – Mali ed Eritrea – hanno sempre votato come Mosca. Segno che i Paesi africani perseguono i loro interessi e che potrebbero decidere di voltare le spalle al Cremlino se ciò dovesse risultare più conveniente.