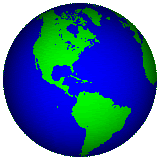Archivio
- Agosto 2025 (10)
- Luglio 2025 (41)
- Giugno 2025 (24)
- Maggio 2025 (9)
- Aprile 2025 (80)
- Agosto 2024 (1)
- Dicembre 2023 (73)
- Novembre 2023 (1333)
- Ottobre 2023 (1631)
- Settembre 2023 (1468)
- Agosto 2023 (1417)
- Luglio 2023 (1389)
- Giugno 2023 (441)
- Maggio 2020 (30)
- Marzo 2020 (65)
- Gennaio 2018 (10)
«L’Apophis? Mai sentito nominare. Ormai sono fuori dal giro»: il racconto della settimana
Arrivati a Portofino da Milano con il treno delle 6 e 10 e con tre ore di sonno alle spalle, ordino un caffè doppio al cameriere del bar Mariuccia in piazzetta senza togliermi gli occhiali da sole e con ancora indosso la felpa rossa con il cappuccio tirato su anche se si muore già di caldo. Mi guardo intorno, tormento la copertina carta da zucchero del piccolo libro di Julien Green pubblicato da Adelphi intitolato Parigi che mi sono portato dietro, accendo l’ennesima Gauloises rossa, la terza, anche se non sono ancora le nove del mattino. La piazzetta è ancora deserta, non ci sono a quest’ora le orde di turisti che tutto il giorno, incessantemente, si riversano nel borgo sputati fuori dalle love-boat, con le bottiglie di plastica di acqua minerale e i panini nello zaino. «Che poi questa cosa non l’ho mai capita. Che cosa ci vengono a fare i turisti qui a Portofino?», chiedo a Ofelia. «Non ci si abbronza, non si nuota, non si fanno tuffi. Non c’è una striscia di sabbia a pagarla oro, un pattino, un ombrellone. Nada». «Esatto», risponde lei caustica, «infatti vedo in giro solo qualche marinaio di qualche equipaggio e un paio di miliardari con l’artrosi scesi da qualche yacht». Tutt’intorno a perdita d’occhio solo una giungla di alberi e di scafi, che tra poco molleranno gli ormeggi diretti verso la Sardegna o altre mete, come accadrà tra poco a noi due, pronti a imbarcarci su una barca a vela presa a nolo e fare rotta verso la Francia. «Pensa che la prossima volta che toneremo qui a Portofino», le dico, «probabilmente avranno ribattezzato Piazza Martiri dell’Olivetta Piazza Silvio Berlusconi. Leggevo l’altro giorno sul Messaggero che sarà il primo Comune a intitolare una via al Cav. Probabilmente sarà una piccola strada che porta al cancello di una villa qui sopra dove stava quando veniva da queste parti. Villa dell’Olivetta, per la precisione. La inaugureranno a settembre, nel giorno del suo compleanno». «Non mancherò per nessun motivo al mondo», risponde lei, ancor più acida, alzandosi dal tavolo e, contemporaneamente, chiedendo il conto al cameriere. «Andiamocene».
«Pensa che la prossima volta che toneremo qui a Portofino probabilmente avranno ribattezzato Piazza Martiri dell’Olivetta Piazza Silvio Berlusconi. Leggevo che sarà il primo Comune a intitolare una via al Cav. La inaugureranno a settembre, nel giorno del suo compleanno»
Avevamo salpato l’ancora alle nove del mattino precise e l’equipaggio, oltre allo skipper e la sua fidanzata che ricopriva il ruolo di hostess, era così composto: io & Ofelia, la mia amica Stella e mia cugina Rebecca più i loro rispettivi fidanzati, Carlo e Leonardo. Per tutta la durata del giorno il mare si era mantenuto calmo e per vaste estensioni la superficie delle acque era trasparente e tiepida. Arrivati a destinazione, dopo quasi nove ore di navigazione filate, intorno alle sei di sera nella baia di Villefranche, erano state stappate diverse bottiglie di vino, soprattutto etichette francesi tipo Chablis e Muscadet, e l’aperitivo andò avanti finché tutte le bottiglie non furono vuote. Quasi tutti gli italiani che arrivano in barca qui in Costa Azzurra da Sanremo, Alassio o dalla stessa Portofino, preferiscono generalmente compiere la prima tappa nel porto di Monaco. Noi come il mese scorso abbiamo deciso invece di fermarci in rada davanti al bellissimo porticciolo di Saint Jean-Cap Ferrat, una piccola penisola rocciosa e immersa nel verde, a pochi chilometri da Montecarlo, in cui la vita scorre lenta, e dove è del tutto normale vedere la gente passeggiare con la baguette sottobraccio o sorseggiare rosè in spiaggia all’ora del tramonto. Leopoldo II del Belgio, che da queste parti possedeva 50 ettari di terreno, la definiva «la proiezione terrestre del Paradiso». Imponenti recinzioni, sistemi d’allarme e guardie del corpo difendono quello che succede all’interno delle ville delle due punte. «Quando venivamo qui da piccoli con i miei, prima che comprassimo la casa in Sardegna», dice mia cugina Rebecca, mentre ci beviamo una birra seduti uno di fronte all’altra al solito Le Cadillac, «ricordo che tutta la vita di giorno si svolgeva in mezzo al mare, sulle barche, perché in alto, nella zona delle ville, praticamente non c’è spiaggia. I condomini per i comuni mortali come noi, invece, stanno tutti qui intorno».

Mentre parla la osservo, ancora bellissima come è sempre stata, con le gambe nude e una felpa con il cappuccio blu, e mi rendo conto che da tempo non è più la bambina che tenevo sulle ginocchia ma una donna di 35 anni, con tre figli e le idee chiare. Mentre penso a tutte queste cose mi accorgo che due tavoli di fianco a noi è seduto un ragazzo di Milano che conosco: il Duca. È in compagnia di una ragazza, tra di loro, appoggiata in un secchiello del ghiaccio sul tavolo, troneggia una bottiglia di Tattinger. «Andrea Spider!», urla appena mi vede, «cosa ci fai da queste parti?», mi domanda incredulo, e quando mi alzo per andargli incontro e salutarlo sorridiamo entrambi, perché ci rendiamo conto quasi in contemporanea di essere vestiti esattamente nella stessa maniera: t-shirt bianca, bermuda beige, scarpe da barca. «Come diceva lo scrittore inglese William Somerset Maugham, che qui era di casa, cos’è la Costa Azzurra se non un luogo soleggiato per gente losca? Ciao Duca, come te la passi? Lei è mia cugina Rebecca», gli dico. «Ah scusatemi, che maleducato, lei è Valentine», mi risponde lui, alzandosi a sua volta dal tavolo e indicando la ragazza seduta di fronte. «Conosco il Duca dal 1998», dico a mia cugina, «siamo finiti insieme un anno al liceo in una di quelle scuole private per disadattati che facevano recupero anni e poi abbiamo lavorato assieme per parecchio tempo nei locali. Era il periodo delle discoteche minorili, delle one night, delle serate. È grazie a lui che ho cominciato a parlare al microfono dalle consolle di mezza Milano», aggiungo. «Eri già Andrea Spider, una star delle pubbliche relazioni dei pomeriggi milanesi», risponde lui e poi continua, «io ho fatto solo in modo che diventassi una street legend. All’epoca erano in pochi quelli che parlavano al microfono. Poi sei arrivato tu e la cosa di colpo è diventata cool. Da quel momento in poi tutti i ragazzini volevano farlo». Poi ci sediamo al tavolo tutti e quattro assieme, il Duca ordina un’altra bottiglia di Tattinger e il discorso scivola inevitabilmente su Apache e l’Apophis, la discoteca dove è iniziata la brutta storia che per tutta questa settimana ha occupato le prime pagine dei giornali. «Cosa ne pensi?» chiedo al Duca. «Dove vuoi arrivare? Dimmelo subito». «Mah, non voglio arrivare da nessuna parte e nemmeno entrare nei dettagli della vicenda. Però devo dirti che la storia mi ha parecchio incuriosito, a prescindere dal cognome dell’indagato, fondamentalmente per due motivi. Primo, perché il fatto sarebbe avvenuto praticamente davanti a casa mia. Secondo, perché l’Apophis è un locale che non ho mai sentito nominare e la cosa mi ha fatto sentire terribilmente fuori dal giro. Oltre che, ovviamente, tremendamente vecchio». «I tempi cambiano Spiderino, è normale».
L’Apophis è un locale che non ho mai sentito nominare e la cosa mi ha fatto sentire terribilmente fuori dal giro. Oltre che, ovviamente, tremendamente vecchio
Tra l’università e la biblioteca Sormani c’è una piccola stradina che si chiama via Merlo. In fondo, quasi all’angolo con via San Bernardino, sormontato da una verandina blu navy con sopra un serpente stilizzato c’è l’ingresso dell’Apophis, un piccolo club di 180 mq tra i più esclusivi in città. Disegnato da un noto studio di architettura il locale è una bomboniera da 200/300 persone. Solito giro milanese di pierre e deejay che organizzano feste e one night, all’Apophis ci vanno i figli dei politici, dei professionisti, degli industriali. I cognomi in vista della Milano che conta, insomma. Hanno più o meno tutti intorno ai 20 anni, hanno frequentato i migliori licei e le più esclusive scuole ambrosiane, il Parini, il Berchet, il San Carlo, il Leone XXIII e solitamente fanno avanti e indietro da Londra, dove studiano economia o design. Per entrare bisogna essere soci, la tessera annuale costa intorno ai 500 euro e si dice che tra i suoi divani di velluto raso, oltre a fiumi di vodka e caviale Beluga, giri anche parecchia cocaina. Così dicono i giornali, stupendosi quasi della cosa, come fosse strano che nelle discoteche del centro giri della droga e come fosse inconsueto che i rampolli delle famiglie bene milanesi frequentino certi locali. Succedeva anche ai miei tempi con il Madame Claude, con lo Yachting Club, con lo Stage di via Manzoni, con il Propaganda e compagnia bella, anche se a essere totalmente sincero io di droga ne ho vista sempre più a scuola che nei locali. Come all’Oppenheimer ad esempio, dove si basava cocaina nei bagni e dove al cambio dell’ora per 10 mila lire potevi farti una riga lunga quanto la diagonale del diario dell’istituto. E anche in quanto alla violenza, a parte qualche sparuto gruppo di pistoleri figli di avvocati e notai che giocavano a fare i cow-boy, sotto le luci strobo delle discoteche frequentate da certi giri, non ce n’è mai stata granché. Ci si sfogava più che altro sulle cose che sulle persone. Si vandalizzavano le feste, si depredavano gli appartamenti patrizi, si distruggevano salotti e camere da letto dei genitori di qualche malcapitato che aveva avuto l’ardore di festeggiare il compleanno a casa. Null’altro. Di stupri e robaccia simile in tanti anni non ne ho mai sentito parlare. Nemmeno una volta. Non era roba per noi. Mai si sarebbe messa della droga nel bicchiere di una ragazza per portarsela a letto. Se c’era della droga volevamo spararcela tutta noi, qualsiasi essa fosse.

Il giorno dopo in rada a Cap Ferrat il sole in cielo era una palla di fuoco e il caldo africano rendeva incandescente perfino il ponte in tek della barca. Anche l’acqua del mare era troppo bollente per offrire un vero sollievo: lavava via il sudore ma non riusciva a raffreddare il sangue che scorreva dentro i nostri corpi. Di tanto in tanto qualche piccola onda increspava di verde smeraldo l’orizzonte, riflettendo la luce del sole con malcelata eleganza e rallentando il turbine di pensieri che si avvicendavano per la malata scatola cranica. Le ragazze stavano a prua, stese su teli color turchese e io le osservavo seduto sono il tendalino al centro del pozzetto, mentre scrivevo con l’iPad sulle ginocchia con indosso una t-shirt con sopra la faccia di Notorious BIG e un cappellino da baseball degli Yankees portato con la visiera a rovescio. Hip-hop anche in barca a vela. Sottocoperta sventolava maraglia la bandiera verde smeraldo della Giraglia con al centro il simbolo giallo della Rolex e mancavano meno di quattro ore alla partenza del treno che da Nizza ci avrebbe riportato a Milano. Fu proprio in quel momento che l’iPhone iniziò a vibrare e aprendo whatsapp si materializzò un’immagine di me, 19enne, appena sveglio in pieno hanghover, in mutande e con indosso la t-shirt dello Stage di via Manzoni, davanti alla portafinestra dell’appartamento di mia zia in Piazza Adigrat. A corredo un messaggio del fido Baj, uno degli amici di una vita: «Guarda nei meandri di una vecchia scatola di scarpe cosa ho trovato? Estate 1999. Ciao!». «Andrea Spider», penso, «la street legend». Già, la street legend che non esiste più.