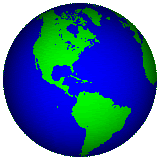Archivio
- Luglio 2025 (41)
- Giugno 2025 (24)
- Maggio 2025 (9)
- Aprile 2025 (80)
- Agosto 2024 (1)
- Dicembre 2023 (73)
- Novembre 2023 (1333)
- Ottobre 2023 (1631)
- Settembre 2023 (1468)
- Agosto 2023 (1417)
- Luglio 2023 (1389)
- Giugno 2023 (441)
- Maggio 2020 (30)
- Marzo 2020 (65)
- Gennaio 2018 (10)
Informazione e pubblicità, perché il decalogo di Repubblica ormai è sorpassato
Recentemente i giornalisti di Repubblica hanno pubblicato il documento Informazione e pubblicità: la carta dei doveri, elencando in 10 punti le difficoltà dei loro rapporti con la concessionaria di pubblicità, in un periodo in cui «gli investitori hanno pochissimo interesse a utilizzare la carta stampata» per promuovere le loro aziende e i loro prodotti. Nel documento si impegnano «a tenere distinta l’informazione dalla pubblicità in tutte le piattaforme: giornale, allegati, sito, social network, podcast, eventi», stigmatizzando le pressioni della pubblicità e richiamando doveri deontologici e trasparenza.
Nell’era di Internet i mercati sono diventati luoghi di incontro e conversazione
È un’occasione interessante per tentare un aggiornamento su giornalismo e pubblicità nell’era di Internet. A leggere il documento della redazione di Repubblica sembrerebbe che niente sia cambiato in questo primo ventennio del nuovo secolo: le regole che dovrebbe seguire un professionista nel suo delicato compito di informare sarebbero sempre le stesse dall’origine della stampa: i fatti separati dalle opinioni (come diceva lo slogan di un settimanale 40 anni fa), l’informazione separata dalla pubblicità. Ma, nell’era di Internet, «i mercati sono conversazioni», secondo una delle 95 tesi del Cluetrain Manifesto, il libro degli economisti del web Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls e David Weinberger che, nel 2000 e poi nel 2016 (con un aggiornamento), ha raccontato come Internet penetri profondamente nella società modificandone i tradizionali equilibri. I mercati sono diventati luoghi d’incontro e di conversazione, le potenzialità informative, gratuite e alla portata di tutti, hanno creato un nuovo tipo di consumatore, competente, esigente, certamente non più assoggettato a una comunicazione unidirezionale. Internet non ha un fine specifico: è stato progettato per informare, fare pubblicità, comprare, vendere, regalare; per diffondere messaggi religiosi e video pornografici; immagini drammatiche e frivole; proclami politici e opinioni personali. È stato inventato per attrarre gli opposti e restituirli senza mediazioni: è questa la vera rivoluzione di un mezzo che tiene insieme il buono e il cattivo, il virtuoso e il corrotto, l’abominevole e il sublime.
Toscani usando la foto dello sbarco dall’Albania dimostrò che nessuno poteva arrogarsi la prerogativa di informare in modo neutro
Nel 1991, Tim Berners-Lee usò la rete per regalarci il World Wide Web, insegnandoci a scrivere una pagina che può collegarsi a decine, centinaia di altre pagine senza chiedere il permesso a nessuno. Le interconnessioni a cui ci hanno abituato 30 anni di web ci hanno fatto assimilare il concetto che ognuno di noi può usare questo “luogo”, chiunque può esprimere un’opinione con la certezza che qualcuno lo ascolterà. Sempre nel 1991, mentre nasceva il web, c’era stato un marchio italiano, United Colors of Benetton che, sotto la guida creativa di Oliviero Toscani, aveva gettato le basi per questa “confusione”: in quell’anno, il primo sbarco di immigrati albanesi sulle coste italiane, in un’immagine acquistata da Benetton dall’agenzia americana Magnum, veniva usato sia per pubblicizzare il brand, con il logo ben visibile a destra della foto (su grandi poster stradali e su pagine di quotidiani e riviste) sia come copertina della rivista Colors, un vero e proprio “prodotto giornalistico”, con direttore responsabile (Tibor Kalman) e redazione di giovani giornalisti.

Un’altra immagine, della fotografa Therese Frare, quella del malato di Aids David Kirby ripreso sul suo letto di morte circondato dai familiari, era stata pubblicata dalla rivista americana Life: Toscani la scelse per pubblicizzare la Benetton, mettendoci sopra il logo aziendale e comprando spazi a pagamento su vari mezzi, affissioni, riviste di moda, quotidiani, spot in tv. Un esperimento che fece capire, già allora, che nessuno poteva più arrogarsi la prerogativa di “informare” in modo neutro; che informazione e profitto convivevano; che anche la pubblicità poteva essere un mezzo molto potente per comunicare qualsiasi cosa, non solo fustini di detersivo. Si accusò, allora, la Benetton di «sfruttare le immagini del dolore per vendere maglioni». Ma anche due altre aziende, prima della Benetton, l’agenzia fotografica Magnum e la Time Warner, proprietaria della rivista Life, avevano sfruttato due immagini per fare profitti. La Magnum vendendo la foto dello sbarco degli albanesi a Benetton. Time Warner usando quella di Therese Frare per vendere la sua rivista, avendola piazzata in copertina: proprio come stava facendo la Benetton che usava queste due immagini per diffondere messaggi positivi di inclusione ma, certamente, senza dimenticare il fine principale di vendere i propri prodotti. La domanda che allora i media di tutto il mondo si posero fu: perché Magnum e Time Warner possono fare profitti e Benetton no, usando le stesse foto, comprandole da loro, e pubblicandole in affissione, su riviste e giornali? La foto di un malato di Aids messa in copertina di una rivista – si presume per attirare il pubblico a comprarla – andava bene, determinando un guadagno per il gruppo editoriale che ne era proprietario, ma era sconveniente se la usava un’azienda di abbigliamento per farsi pubblicità? Andava bene per vendere un giornale ma non per vendere un maglione?

La presunta verità rivelata dei giornalisti oscurata in pochi secondi da un video su TikTok
Il mondo è profondamente cambiato, di questo sembrano non accorgersi i giornalisti che hanno redatto la Carta dei Doveri di Repubblica: i branded content che spaventano la redazione sono soltanto un altro dei mille modi di informare. «Se volete che i vostri clienti continuino a parlare di voi e a comprarvi, raccontategli qualcosa: possibilmente qualcosa di interessante»: il Cluetrain Manifesto aveva capito che nell’era di Internet le imprese – qualsiasi impresa: anche quella della famiglia Elkann proprietaria di un quotidiano come la Repubblica – se vuole continuare a fare profitti deve «raccontare qualcosa di interessante» ai suoi stakeholder, che siano lettori o clienti finali di qualsiasi cosa, più che rinchiudersi nella fortezza di un rigore deontologico che non basta più. È sorpassato come imperativo morale – se resta solo quello – perché, paradossalmente, l’informazione veicolata dagli uffici stampa delle imprese è forse l’unica veritiera in un proliferare di interpretazioni e di fake news. Del resto le imprese sono sempre di più soggetti sociali: l’azienda “cittadina” (l’industrie citoyenne la chiamano i francesi), proprio come una persona interessata alla società di cui è espressione e motore dei suoi cambiamenti, non solo economici, verso stili di vita cooperativi e associativi, legittimata a intervenire sui temi che coinvolgono le comunità, con modalità di governance più partecipative e egualitarie. Aziende sempre più orientate alla trasparenza, verso l’abbattimento delle differenze di genere e di culture, verso modelli virtuosi di economia circolare. Non sono esenti da questi cambiamenti le imprese editoriali private che pubblicano quotidiani come la Repubblica. Anche loro, in quanto aziende private, sono chiamate a misurarsi con i nuovi mercati interconnessi, pena l’impietosa esclusione dagli stessi. I giornalisti non sono più la categoria di lavoratori che mantiene per statuto il privilegio della deontologia professionale, come se fossero l’ultimo baluardo delle verità rivelate, nella mitizzazione del vecchio reportage, mentre il video di un tiktoker ha il potere in pochi secondi di oscurarli, raggiungendo milioni di contatti.
Sarebbe stato più interessante leggere un decalogo sulle sfide poste dall’Intelligenza artificiale
Certo, è più facile denunciare le “pressioni” delle concessionarie di pubblicità, riconoscibili, al contrario di quelle occulte che vanificano il lavoro del giornalista tradizionale, costretto sempre più spesso a spettacolarizzare le sue corrispondenze, per adeguarsi alla obsoleta regola dell‘infotainment (in Italia prendiamo ancora sul serio reperti di vecchia tv generalista come Striscia la notizia e Le iene). Non è la «purezza dell’informazione indipendente» rivendicata dagli estensori del Decalogo di Repubblica ad appassionarci. I giornali non sono mezzi efficaci più di quanto lo siano le nostre conversazioni in Rete. Siamo umani e comunicare è una delle nostre principali attività: qualunque link postato da uno sconosciuto che ha qualcosa da dire è un atto di generosità, che invita i lettori ad abbandonare le loro pagine rassicuranti per buttare uno sguardo al mondo com’è visto dagli occhi di un’altro. Sarebbe stato interessante leggere un decalogo di questo tipo, un Cluetrain Manifesto del giornalismo 4.0 alle prese con le sfide dell’Intelligenza artificiale, invece delle lamentele già sentite sullo strapotere della pubblicità.
*Paolo Landi è advisor di comunicazione per imprese, autore di Instagram al tramonto (La Nave di Teseo, 2019) e dell’imminente La lotta di classe degli algoritmi (Krill Books).